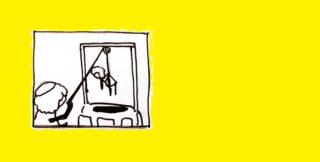E’ interessante studiare uno stesso tema da più prospettive. Non è solo l’opinione di molti studenti, l’esperienza ci fa dire che è anche didatticamente più efficace. In questa classe, la 3D del 2016/2017 alla Leonardo da Vinci, si studiava la guerra in italiano (la letteratura neo-realista) e in storia (la seconda guerra mondiale), e Giorgia scrisse questo testo, dal punto di vista di un IMI (Internato Militare Italiano) prigioniero in Germania.
.
Mi chiamo Luigi Ferrari e ho vissuto in prima persona la seconda guerra mondiale. Stavo vivendo uno dei momenti più belli della mia vita: ero fidanzato con una bellissima ragazza reggiana che lavorava come infermiera in un ospedale e io stavo finendo i miei studi per diventare un insegnante di italiano.
Un giorno vidi Marisa correre verso di me con il viso pieno di lacrime. Non capivo cosa stesse succedendo, sino a quando, stringendomi forte al petto, mi disse che presto saremmo diventati genitori. Rimasi un attimo confuso, ero contento di diventar padre ma intravedevo delle difficoltà nel portare a termine i miei studi. Passato un mese io e Marisa, dopo molte discussioni, riuscimmo a trovare la strada giusta per il nostro futuro, non più come coppia ma come famiglia.
Una mattina, mentre mi preparavo per andare fuori a trovare un mio amico, sentì bussare alla porta in modo molto deciso e violento; io aprì la porta e vidi che era arrivata una lettera per me. Non capivo proprio cosa fosse; non avevo scritto a nessuno e non avevo nessun parente lontano che mi volesse scrivere… allora cos’era? Carico di curiosità aprì la lettera, lessi e subito le gambe allentarono la presa e caddi sul divano. Non ci potevo credere, ero terrorizzato, sarei dovuto partire per il servizio militare. Non potevo fare niente, non avevo nessuna altra possibilità, era un obbligo, un ordine. Dentro di me pesavo: io ho solo 20 anni, sto seguendo degli studi e addirittura tra poco diventerò padre. Non sapevo come dirlo a Marisa, non potevo lasciarla così, in attesa di un bambino, e andarmene… e forse per sempre; ma non avevo scelta, dovevo dirglielo.
Mi ricordo che lei quella sera tornò a casa stanchissima, così io pensai di non dirglielo subito ma di aspettare ancora un po’. Era però un peso troppo grande che non riuscivo a trattenere e glielo dissi. Ricordo che anche lei rimase impietrita da quella mia notizia; subito mi chiese quando sarei dovuto partire. Io risposi che sarei dovuto partire dopo tre mesi. Alla mia risposta cominciò a piangere a dirotto e singhiozzando mi disse: “Neanche il tempo di conoscere tuo figlio”. Dentro mi sentivo morire, ma per il suo bene non potevo piangere anch’io, dovevo farmi forza e tirarle su il morale, infine dopo pochi mesi sarebbe diventava mamma. Provai a rassicurarla dicendo che sarei tornato presto e ogni qualvolta mi fosse stato possibile sarei corso da lei, anche se in cuor mio sapevo che questo non sarebbe accaduto.
Il 21 gennaio 1941 sono partito da Reggio Emilia; prima di partire ho abbracciato forte la mia fidanzata e mi sono abbandonato al destino, senza sapere cosa sarebbe accaduto. Da Reggio E. ero diretto verso l’Aquila, dove mi sarei preparato a quella che sarebbe stata la mia esperienza di guerra. Dopo esser stato un mese nel territorio abruzzese mi hanno mandato a Bari per esercitarmi all’uso della mitragliatrice. Quando ho visto quell’arma nelle mie mani, per un attimo non ho capito più niente, io in quel momento dovevo essere a casa mia con mia moglie o addirittura in ospedale a conoscere mia figlia o mio figlio, invece ero lì ad imparare a utilizzare un’arma.
Dopo tre mesi di preparazione ero pronto e sono partito per la Grecia. Arrivato in Grecia non mi hanno fatto combattere, ma mi avevano detto che avrei fatto il falegname perché ero giovane e quindi avevo la forza per compiere quel lavoro.
Eravamo male addestrati e poco armati. Sono stato impiegato a Laris, una cittadina non molto grande, e vivere lì non era semplice: la Grecia era messa male allora. Il costo dei viveri era tremendo. Un chilo di pane poteva costare anche mille dracme. Ricordo che ogni sera, quando rientravo dal posto di lavoro, una bambina mi aspettava: sapeva che le avrei dato metà del mio rancio. Per fortuna, non ho dovuto combattere, grazie al mio mestiere. Ma ho visto tanta fame, e tanta malattia. C’era la malaria lì, in estate. Mentre in inverno il rischio era quello di restare congelati.
Il nostro rapporto con i tedeschi era un rapporto tranquillo. Ci davano anche porzioni di rancio, ma niente di che, un po’ di brodo al massimo. Loro, invece, mangiavano la pasta e le patate. Ci si poteva ragionare, come uomini, ma non come soldati. Perché la loro legge militare era superiore alla nostra, più rigida, perché Hitler era un dittatore pazzo. I tedeschi, inizialmente, non erano arroganti con noi. Lo sono diventati dopo.
.
Dopo due anni di guerra, quel 8 settembre del 1943, l’armistizio ci portò una grande gioia. Ma il nostro colonnello ci disse che, per noi, la guerra non era finita, e che non saremmo tornati a casa. C’era grande confusione e incertezza: non si sapeva dove andare. Non si sapeva se stare con i tedeschi, o contro di essi. Poi il nostro Colonnello preferì la resa, e farci prendere prigionieri, piuttosto che farci mitragliare dagli ex alleati. Sapeva che non avremmo potuto difenderci. Da quel momento iniziò un incubo, io pensavo che fosse tutto finito e che sarei tornato a casa, invece era solo l’inizio del mio “percorso”. Poteva accadermi di tutto, persino finire in un campo di concentramento; per me, come per molti altri prigionieri, significava morire e prima della morte soffrire, soffrire tanto e lavorare, lavorare finché… “non servivi più”.
Dalla Grecia siamo partiti per Ravensbruck, un campo vicino Berlino, questo campo era uno dei nodi centrali di quelle vaste reti di campi. Appena arrivati al campo, solo i prigionieri dichiarati abili al lavoro venivano condotti negli edifici dei veri bagni, io per fortuna ero uno di quelli. Lì dovevo, anzitutto, consegnare biancheria ed abiti civili, nonché tutti i monili di cui ero in possesso; poi sono stato privato, inoltre, dei documenti d’identità che possedevo. Mi ricordo che mi avevano tolto tutto tranne un fazzoletto di stoffa e la cintura dei pantaloni.
Successivamente, sono stato spinto nel locale in cui sono stato consegnato ai barbieri, che mi hanno rasato tutto il corpo. L’operazione l’hanno condotta in maniera sbrigativa e poco interessata. Dopo di che mi hanno vestito con l’abbigliamento del campo e mi hanno registrato: veniva compilato un modulo con i dati personali e con l’indirizzo dei familiari più prossimi. Qui per me arriva la parte più difficile da raccontare, cioè il tatuaggio che mi è stato registrato sul braccio, da quel momento io non ero più Luigi Ferrari, ma il semplice numero 13258.
Il mio ruolo lì era principalmente il falegname, perché, ormai, ero diventato esperto in questo ambito. Le giornate dentro al campo si alternavano tra comandi, punizioni fisiche, grandi quantità di lavoro ma soprattutto nell’aria si sentiva grande “profumo di morti”. L’unico pensiero che mi faceva andare avanti era rivedere presto la mia Marisa.
Dopo quattro mesi di continuo lavoro da falegname, mi hanno comunicato che io avrei iniziato a fare da cuoco/cameriere al generale Walter Alf. Devo dire che quel lavoro mi appagava di più e dopo giorni, settimane e mesi era diventata una vera e propria passione. Mi sono accorto che il generale che servivo mi aveva preso particolarmente in simpatia e per questo io volevo ricambiarlo impegnandomi a preparare buone pietanze.
Il 5 gennaio del 1944 io ed alcuni miei compagni siamo stati radunati davanti al muro delle esecuzioni. Ho capito subito che per noi era la fine. Ci hanno fatto inginocchiare ed immediatamente hanno iniziato ad ammazzare uno dopo l’altro i miei compagni. Dopo pochi istanti sarebbe toccato a me quando una voce tedesca, sovrastando il rumore dei fucili, interruppe l’esecuzione. Da quella stessa voce, dal suono famigliare, sentì pronunciare la frase: “Nein, warten! Der Sechste ist jung und smart… Er kann uns dienen, hat noch nützliche Kräfte”. No, aspetta, il sesto è giovane e in gamba, ci può servire, ha ancora delle forze utili, diceva quella voce. In maniera timorosa alzai la testa e vidi proprio lui, il generale Walter Alf, che mi invitava ad alzarmi e raggiungerlo. Non me lo feci ripetere la seconda volta e, correndo verso di lui, sentii riprendere le fucilazioni. Ero chiaramente felicissimo di essere scampato alla morte, ma vedere morire i miei compagni è stato terribile e nelle mie orecchie, ancora oggi, si ripropone il rumore di quegli spari.
Da quel momento sapevo di essere sopravvissuto a quella fucilazione, ma per me come per tutti i miei compagni, la guerra non era finita, lavorare era l’unica cosa che ci rimaneva da fare, anche se ormai le mie condizioni fisiche erano allo stremo. Diventai ufficialmente il cuoco personale del generale Walter Alf. Le giornate erano tutte uguali, non riuscivo ormai a provare emozioni di nessun genere.
Ero 13258 al servizio del generale, non avevo più nessuno che aspettava il mio ritorno, non avevo più alcuna speranza di tornare nella mia amata terra, non avevo più sogni né desideri, non riuscivo più a credere a nulla di positivo; ma continuavo ad andare avanti, perché non potevo credere che potesse finire così, dopo anni di lavoro e sofferenza dovevo aggrapparmi a qualcosa per continuare.
Il 2 settembre 1945, con l’arrivo degli americani, fu ufficialmente dichiarata la fine della guerra. Finalmente non ero più 13258, ma ero tornato ad essere Luigi Ferrari; era difficile da credere ed era difficile gioire perché bastava guardarmi intorno per vedere ceneri e macerie e nell’aria odore di polvere da sparo.
.
Gli anni passarono, riuscii a laurearmi e diventai maestro di una scuola elementare a Reggio Emilia. Di frequente, ai miei alunni, raccontavo la mia storia, serviva a me per non dimenticare e a loro per sapere. Ogni volta che raccontavo la mia storia un brivido mi percorreva lungo la schiena e il mio cuore batteva forte. Dimenticare era impossibile, alternavo ricordi tristi a momenti di grande tenerezza con i miei compagni, mi sembrava di sentire ancora i loro forti abbracci, i loro incoraggiamenti. “Non mollare, Luigi! – mi dicevano – Vedrai che ce la faremo, finirà”.
Pochi anni dopo mi sposai, lei era una mia collega e presto dal nostro amore nacque una bellissima bambina che chiamai Marisa, in ricordo della mia amata Marisa che, come seppi, morì poco tempo dopo la mia partenza, prima ancora di dare alla luce il frutto del nostro amore.
.
GIORGIA, 2017